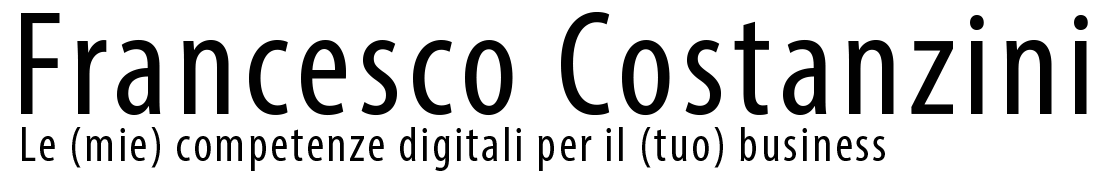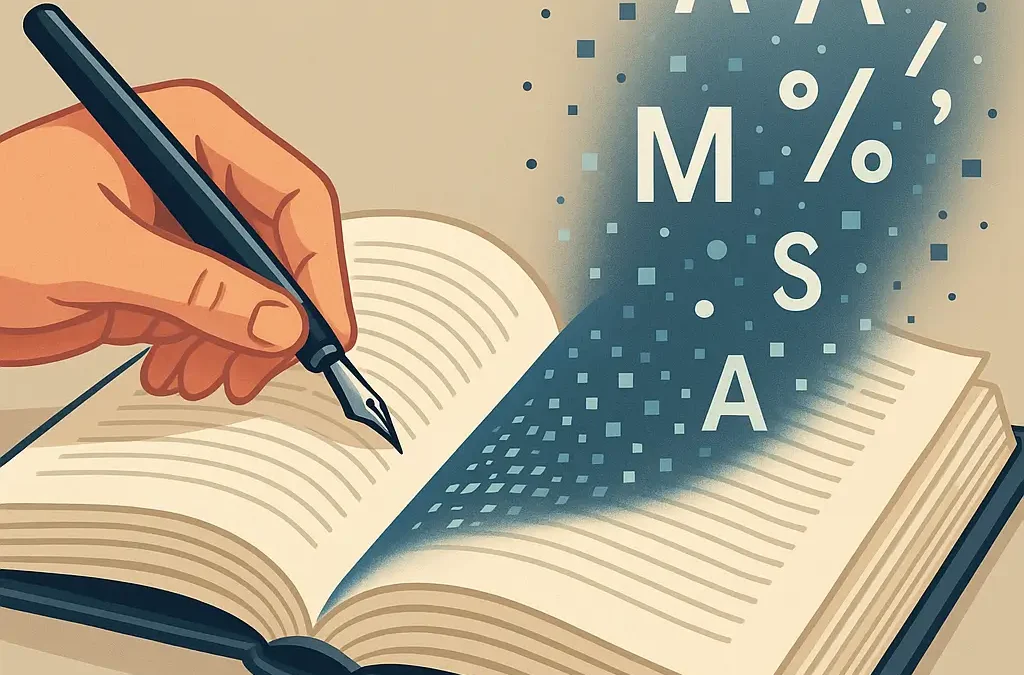Mai come oggi il tema del copyright è stato messo alla prova dalle tecnologie di intelligenza artificiale generativa.
Strumenti in grado di creare testi, immagini, musica o video hanno spalancato nuove possibilità, ma allo stesso tempo hanno aperto un fronte di discussione che tocca artisti, aziende, scuole e istituzioni.
Per affrontare questo argomento, non essendo un giurista, mi sono affidato a ricerche approfondite condotte con vari strumenti di AI e all’incrocio delle loro funzionalità. Ho cercato risposte a dubbi reali e ho messo insieme prospettive diverse, dalle normative ai casi pratici.
Se ci fossero obiezioni da parte di addetti ai lavori su alcune interpretazioni, sono aperto a modificare e correggere il tiro: perché su questi temi, più che mai, serve confronto.
Chi è il vero autore di un’opera realizzata con l’aiuto dell’IA?
La domanda non è soltanto teorica: riguarda la tutela di chi crea, le responsabilità di chi utilizza questi strumenti e le incertezze di un quadro normativo ancora in evoluzione.
In questo articolo ti accompagno tra diritti, limiti e opportunità legate all’uso dell’AI generativa, facendo riferimento alle novità legislative e ad alcuni casi emblematici.
L’obiettivo non è dare risposte definitive, ma offrire una bussola per orientarsi in un terreno che cambierà ancora molto nei prossimi anni.
Cos’è l’AI generativa e perché mette in discussione il copyright
L’intelligenza artificiale generativa è una tecnologia capace di creare contenuti originali (testi, immagini, suoni e video) in risposta a richieste dell’utente. Funziona grazie a modelli addestrati su enormi quantità di dati, spesso provenienti dal web, tra cui possono esserci anche opere protette da copyright.
Il problema nasce proprio qui: per “imparare” a generare nuovi contenuti, l’IA utilizza materiali che appartengono ad autori, artisti o aziende, senza sempre ottenere un’autorizzazione preventiva. È il caso delle immagini nello stile dello Studio Ghibli o dei brani musicali ricreati a partire da campioni esistenti: opere che non solo sollevano dubbi di originalità, ma che rischiano di violare i diritti di chi quelle opere le ha realmente create.
Le questioni diventano ancora più delicate quando si guarda agli output: un testo, un disegno o una canzone prodotti interamente dalla macchina possono essere considerati opere tutelabili? Alcuni giuristi parlano di una “zona grigia”, perché la legge attuale riconosce la protezione del copyright solo quando c’è un apporto umano creativo, rilevante e dimostrabile.
Come ha sintetizzato un’analisi legale: “Il contributo umano nelle opere create attraverso l’ausilio di strumenti di IA deve essere creativo, rilevante e dimostrabile” (Osborne Clarke, 2024). È questo il nodo che porta a ridefinire il confine tra strumento e autore, tra ispirazione e appropriazione.
Chi è l’autore? Il nodo della titolarità dei diritti
Il punto più delicato riguarda l’autorialità: chi può dirsi davvero autore di un contenuto creato con l’ausilio dell’IA? La risposta, oggi, non è affatto scontata.
Secondo la normativa italiana, la tutela del diritto d’autore si applica soltanto quando l’opera è “risultato del lavoro intellettuale dell’autore” (DDL 2025). Anche l’Unione Europea ribadisce che l’opera deve portare l’impronta della personalità umana, e a livello internazionale emerge un consenso: senza apporto creativo umano non c’è protezione.
Gli esempi parlano chiaro.
La fotografia A Recent Entrance to Paradise, generata dal sistema AI Creativity Machine, non ha ottenuto tutela perché creata in piena autonomia dalla macchina. Al contrario, un’immagine digitale floreale realizzata con un software è stata ritenuta proteggibile, in quanto l’elaborazione finale rifletteva scelte creative prevalenti dell’utente. Allo stesso modo, se una persona interviene regolando prompt e parametri fino a ottenere un risultato che esprime la propria visione estetica, quel contributo può essere considerato sufficiente a rivendicare i diritti sull’opera.
Come hanno ricordato diversi giuristi, “la tutelabilità di un’opera creata con l’ausilio della tecnologia è rimessa alla valutazione fatta caso per caso dai giudici” (Caso Ghibli, 2025). Ed è qui che si gioca la partita: stabilire quando l’IA è semplice strumento e quando diventa qualcosa di più.
Le conseguenze pratiche non sono di poco conto. Per gli autori, c’è il rischio che opere interamente generate dall’IA restino in un limbo, replicabili da chiunque senza alcuna protezione. Per le aziende, l’incertezza sulla titolarità degli output complica la possibilità di valorizzare commercialmente i contenuti creati internamente con questi strumenti.
In altre parole, il nodo della titolarità dei diritti non riguarda solo artisti e creativi, ma tocca l’intero ecosistema che ruota attorno alla produzione e circolazione dei contenuti.
I limiti normativi e le incertezze legali
Se da un lato la tecnologia corre, dall’altro le regole arrancano.
Il Disegno di Legge approvato in Italia nel Settembre 2025 ha introdotto alcuni principi chiave: la protezione è garantita solo quando l’opera è frutto dell’ingegno umano, i contenuti generati da sistemi di IA devono essere chiaramente identificati, e viene disciplinato l’uso del text and data mining (TDM) per l’addestramento, prevedendo un opt-out a favore degli autori.
Non mancano inoltre nuove sanzioni penali contro l’abuso o la diffusione illecita di contenuti alterati con l’IA.
Anche l’Europa ha fatto la sua mossa. L’AI Act impone ai fornitori di modelli di pubblicare una sintesi delle fonti usate per l’addestramento e di rispettare le riserve di diritti espresse dai titolari. Tuttavia, resta dibattuta l’efficacia delle eccezioni previste dalla Direttiva Copyright: in teoria il TDM dovrebbe consentire analisi su opere accessibili legalmente, ma nella pratica l’uso massivo dei dati rende difficile distinguere cosa sia lecito e cosa no.
A rendere il quadro ancora più complesso ci sono le controversie legali. Getty Images ha citato Stability AI per l’uso non autorizzato di milioni di immagini, sostenendo che persino il modello di generazione sarebbe una “copia contraffatta”. In Germania, la GEMA ha accusato OpenAI di aver utilizzato testi di canzoni protette senza licenza. Sono casi che mostrano come le incertezze giuridiche possano rapidamente trasformarsi in conflitti aperti tra aziende e società di gestione dei diritti.
E a livello internazionale? Negli Stati Uniti vige la dottrina del fair use, più flessibile e orientata a favorire l’innovazione se l’uso è considerato trasformativo. In Europa, invece, prevale un approccio più rigido fondato sui diritti esclusivi e su eccezioni specifiche, che in teoria tutelano di più gli autori, ma in pratica lasciano molte aree grigie. Alcuni Paesi, come Regno Unito e India, hanno previsto una protezione ad hoc per le opere “computer-generated”, mentre in generale l’incertezza resta la vera costante di quasi tutte le giurisdizioni.
Come ha sintetizzato un’analisi: “Il fenomeno sta assumendo una dimensione così importante che, se non debitamente regolamentato, potrebbe sfuggire al controllo” (Caso Ghibli, 2025). Una frase che racchiude perfettamente lo stato attuale delle cose: un sistema normativo che rincorre, senza ancora riuscire a fissare paletti solidi.
Le opportunità per aziende, scuole e persone
Accanto a rischi e incertezze, l’AI generativa porta con sé anche un ventaglio di opportunità che sarebbe riduttivo ignorare. Il Disegno di Legge italiano del 2025, oltre a introdurre vincoli e tutele, riconosce apertamente il potenziale di questa tecnologia per lo sviluppo economico e sociale.
Per le aziende, l’intelligenza artificiale può diventare leva di competitività e innovazione. Significa migliorare l’interazione uomo-macchina, aumentare la produttività, aprire nuove attività economiche e perfino generare un mercato innovativo, equo e concorrenziale. Non solo: si sta delineando un nuovo spazio per le licenze sulle opere e sui dati utilizzati nell’addestramento, capace di offrire una remunerazione più equa ai titolari dei diritti. Non a caso il DDL italiano ha autorizzato investimenti fino a un miliardo di euro per sostenere PMI e imprese innovative nel settore dell’IA e della cybersicurezza.
Nella scuola, il potenziale è duplice: rafforzare le competenze STEM e integrare percorsi formativi sull’intelligenza artificiale, sia nei curricula scolastici che nei corsi universitari e nei percorsi di Alta Formazione.
L’obiettivo è preparare gli studenti a comprendere e utilizzare consapevolmente queste tecnologie. In più, i piani didattici personalizzati per studenti ad alto potenziale prevedono la possibilità di introdurre attività legate all’IA, un segnale di come questa materia non sia più relegata alla ricerca di nicchia, ma entri nel cuore dei percorsi educativi.
Sul fronte personale e creativo, l’IA può diventare un alleato. Può sostenere professionisti e autori nelle attività di supporto intellettuale, offrendo strumenti rapidi e versatili che lasciano comunque spazio all’originalità dell’autore. Può migliorare la vita delle persone con disabilità, facilitando accessibilità, autonomia e inclusione sociale. E, soprattutto, può fungere da strumento creativo se integrata con l’ingegno umano, valorizzando il contributo unico dell’autore senza sostituirlo.
Naturalmente, non esistono solo benefici.
Rimangono rischi come la perdita di informazioni riservate, se utilizzate senza cautela nei prompt, o l’incertezza giuridica che pesa ancora sulla titolarità degli output. Sono aspetti che richiedono attenzione costante e regole chiare.
Le opportunità dell’IA, dunque, non cancellano i limiti: mettono piuttosto davanti alla necessità di un uso consapevole, che sappia sfruttarne il potenziale senza smarrire la responsabilità.
In questo ambito può esserti utile anche il mio articolo su come usare con consapevolezza l’intelligenza artificiale.
Verso un nuovo equilibrio: etica e responsabilità
Norme e sentenze da sole non bastano: il tema dell’AI generativa ci costringe a guardare oltre il diritto, verso una responsabilità etica che riguarda istituzioni, aziende e cittadini.
Il Disegno di Legge italiano del 2025 insiste sulla necessità di una “dimensione antropocentrica”, richiamando il principio che l’IA deve rimanere al servizio della persona e mai il contrario. Per questo si ribadisce l’obbligo di garantire la sorveglianza e l’intervento umano, la tutela della dignità nei luoghi di lavoro e la responsabilità legale che resta sempre in capo a chi sviluppa o utilizza i sistemi.
Anche i report internazionali sottolineano la stessa direzione. La WIPO (agenzia specializzata delle Nazioni Unite per l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) invita le aziende a formare i propri dipendenti all’uso consapevole, affinché comprendano opportunità e rischi, dalle fughe di dati confidenziali alle incertezze legali. Altri studi propongono quadri di remunerazione collettiva per gli autori le cui opere vengono utilizzate nell’addestramento, immaginando un sistema di licenze capace di conciliare interessi creativi e logiche di mercato.
Guardando al futuro, la questione più delicata riguarda l’evoluzione stessa del concetto di autorialità.
I tribunali europei dovranno valutare caso per caso quanto peso abbia l’apporto umano nelle opere ibride uomo-macchina. Parallelamente, stanno emergendo modelli di licenza collettiva che potrebbero trasformarsi in nuovi standard per garantire una remunerazione equa ai creatori.
L’uso di opere protette per addestrare AI richiede un equilibrio tra diritti degli autori e sviluppo tecnologico.
Non si tratta di scegliere tra innovazione e tutela, ma di trovare una convivenza che mantenga al centro la creatività umana, senza bloccare le potenzialità di strumenti che possono migliorare la nostra vita.
In fondo, la domanda è semplice: stiamo assistendo a un conflitto tra uomo e macchina o alla nascita di una nuova alleanza? La risposta, oggi, dipende soprattutto da come sapremo gestire le regole e le responsabilità che accompagneranno queste tecnologie.
Per riflettere più in generale sulla responsabilità digitale, può interessarti anche una mia riflessione sul tema della privacy online.